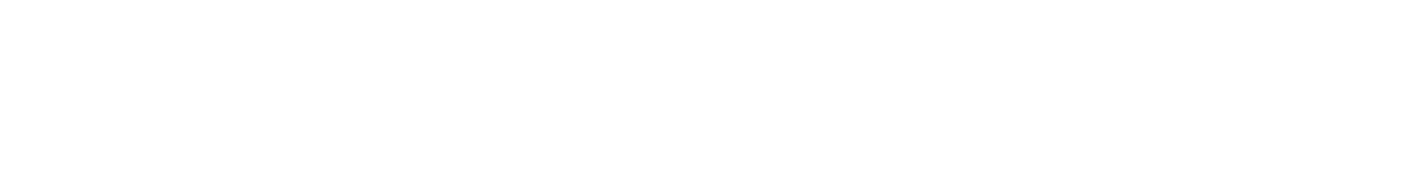Passo tutto il pomeriggio a leggere un libro sdraiata sul letto. Ogni tanto alzo gli occhi dalla lettura e guardo i calzini che indosso, il loro cotone poco convinto di esserlo, e il modo in cui i miei piedi se ne stanno molli sul letto. È la stessa posizione di quando ero ragazza, penso, è lo stesso modo di trascinarmi nei pomeriggi, è lo stesso casino del letto disfatto e disfatto tutt'intorno. I miei jeans a terra, appallottolati insieme ai calzini di ieri e una maglietta bianca.
È una forma che conosco benissimo quella dei vulcanelli di tessuto sbucati dal pavimento di una stanza da letto. Non mi sono mai preoccupata tanto dei miei vestiti. Non sono mai stata una che per dormire in pace ha bisogno che i vestiti stiano ripiegati e ordinati sulla poltroncina.
Penso che la mia pace notturna abbia bisogno di sostenere questioni di ben altro genere di ordine da quello dei vestiti. Lo penso come potrebbe farlo un ateo quando a volte per un attimo gli assale la dolcezza della promessa di pace che avrebbe se solo bastasse quella risposta definitiva e senza proteste e il mondo tornasse in silenzio. A quanto sarebbe più facile se solo avesse quella maledetta fede.
È una forma che conosco benissimo quella dei vulcanelli di tessuto sbucati dal pavimento di una stanza da letto. Non mi sono mai preoccupata tanto dei miei vestiti. Non sono mai stata una che per dormire in pace ha bisogno che i vestiti stiano ripiegati e ordinati sulla poltroncina.
Penso che la mia pace notturna abbia bisogno di sostenere questioni di ben altro genere di ordine da quello dei vestiti. Lo penso come potrebbe farlo un ateo quando a volte per un attimo gli assale la dolcezza della promessa di pace che avrebbe se solo bastasse quella risposta definitiva e senza proteste e il mondo tornasse in silenzio. A quanto sarebbe più facile se solo avesse quella maledetta fede.
Penso a quanto sarebbe più facile se solo bastasse avere dei vestiti piegati su una poltroncina.
Invece mi piace arrivare la sera all'ultimo minuto prima di crollare togliendomi con fare vago i vestiti e buttarli dove capita prima. A mia madre verrebbero gli attacchi di panico nel sonno a pensare a un tale disastro. Io lo trovo un gesto liberatorio. Sono gli ultimi colpi di coda di certi tratti dell'adolescenza mai del tutto risolta, lo so. E oggi non mi crea conflitti saperlo. Sapere che a 34 anni posso ancora a tratti ritenermi libera da certi doveri di donna adulta mi rilassa.
Guardo la chincaglieria polverosa e lontana dal suo solito posto assegnato da chissà quali mediocri regole d'arredamento.
Una volta gli oggetti avrebbero costituito l'unico elemento di disturbo al mio fare disordinato. Se da terra fino all'altezza del letto potevo ammettere con una certa forte dose di tolleranza il disastro, non ho invece mai tollerato il disordine delle forme sulle mensole, i tavolini, le cassapanche, le librerie. Ogni oggetto doveva stare incollato nell'angolo di mondo che gli avevo riservato. Un centimetro di dissonanza mi sembrava intollerabile. In questo ero una specie di nevrotica di fronte ad un quadro non perfettamente allineato.
Oggi invece trovare la giraffa a terra, il gatto di legno sul comodino, la lanterna con la finestrella aperta, mi da esattamente il senso della quotidianità che costruisce le sue storie mettendo fuori posto gli oggetti. La quotidianità non ha altro modo di parlare se non attraverso la voce degli oggetti mossi.
Quella che sta parlando adesso nella stanza da letto è il lavorio di Sofia che ha da poco armeggiato con la paccottiglia degli adulti. Le ho sempre permesso di toccarla. Ho sempre pensato che la bellezza delle mani di mia figlia impegnate a rimaneggiare di nuovo i miei ricordi immortalati sugli oggetti valesse molto di più del rammarico di perderli.
Guardo la chincaglieria polverosa e lontana dal suo solito posto assegnato da chissà quali mediocri regole d'arredamento.
Una volta gli oggetti avrebbero costituito l'unico elemento di disturbo al mio fare disordinato. Se da terra fino all'altezza del letto potevo ammettere con una certa forte dose di tolleranza il disastro, non ho invece mai tollerato il disordine delle forme sulle mensole, i tavolini, le cassapanche, le librerie. Ogni oggetto doveva stare incollato nell'angolo di mondo che gli avevo riservato. Un centimetro di dissonanza mi sembrava intollerabile. In questo ero una specie di nevrotica di fronte ad un quadro non perfettamente allineato.
Oggi invece trovare la giraffa a terra, il gatto di legno sul comodino, la lanterna con la finestrella aperta, mi da esattamente il senso della quotidianità che costruisce le sue storie mettendo fuori posto gli oggetti. La quotidianità non ha altro modo di parlare se non attraverso la voce degli oggetti mossi.
Quella che sta parlando adesso nella stanza da letto è il lavorio di Sofia che ha da poco armeggiato con la paccottiglia degli adulti. Le ho sempre permesso di toccarla. Ho sempre pensato che la bellezza delle mani di mia figlia impegnate a rimaneggiare di nuovo i miei ricordi immortalati sugli oggetti valesse molto di più del rammarico di perderli.
Così quando alzo gli occhi dal libro e guardo le lenzuola stropicciate, attorcigliate attorno al mio corpo sdraiato, il comodino traboccante di altre letture, fogli di manoscritti sparsi, diverse paia di scarpe di tre misure, stili e colori diversi seminate tutt'intorno, già sazia e morbida di tre ore mute di lettura, sento che la mollezza non s'incaglia sugli spigoli del disordine ma continua a sciogliere la pancia.
Leo viene a guardarmi, si ferma prima della porta, è un suo modo tenero ed educato di non infrangere questa specie di luogo intimo che mi sono ritagliata senza il consenso di nessuno tranne che il mio. Rimane lì, mi guarda, poi se ne torna di là.
Entra solo per portarmi la tazzina di caffè fumante. Ammicco un po'. Il modo in cui sto sul letto, le lenzuola e i capelli scompigliati, la mollezza, il caffè. È come il nostro dopo aver fatto l'amore. Leo se ne torna di là ridendo.
In questi giorni mi prendo certe libertà, certe scivolate di stile. Ammicco, scuoto le tette come un'africana disinibita, mi rigiro sul letto languida come una Marilyn catanese mora improvvisata.
Ho perso dieci chili. E acquistato altrettanta sfrontatezza.
L'essere adulta mi ha resa diversa. Mi guardo e mi trovo bella.
Ho addosso dei Gas taglia 29. Mi son fatta il conto con la valuta europea e sulle mie chiappe porto la bellezza del 43. Con il resto di mezzo punto.
Ci sto comoda in questo 43. Mi s'incolla come pelle nelle parti calde ma resta largo e rilassato sulle cosce.
Penso che l'aut aut della taglia in questa parte del mondo sia l'esatta descrizione dei tempi che stiamo vivendo. O 42 o 44.
Nessuna comodità del mezzo punto per te, bellezza. O ti adatti o vai in mutande.
Io me lo chiedo spesso com'è che la gente abbia questo dono innato di adattarsi ai canoni di questa vita. Me lo chiedo quando vedo qualcuno vestito per il pomeriggio e poi si cambia per la sera. Me lo chiedo quando sento qualcuno che sta cambiando il piano tariffario del suo gestore di telefonia. Me lo chiedo quando penso al sabato che è il giorno del parrucchiere.
Io non ho mai avuto questo dono. Si vede perfettamente adesso che sono sdraiata sul letto a godere di questa lettura straordinaria, mentre la mia casa va a scatafascio. Si vede in tante altre decine di cose. Si vede anche su Leo.
Si vede che non ci siamo adattati affatto e che stiamo ancora cercando. Di adattarci? Non lo so.
Mi viene in mente la cassiera all'Auchan dove andiamo a fare spesa. Ha una capigliatura nero corvino lunga, ondulata e selvaggia, raccolta malamente in una specie di chignon incazzato. Me la immagino prendersi i capelli malamente, arrotolarseli alla bell'e meglio e venire qui, in cassa, a passare per l'ennesima noiosa volta una cena come tante, del pane, una zuppa, del formaggio. A volte mi assale una specie di irrequietezza nel veder spiattellata con così poca cura, su un bancone di alluminio, la mia intimità, la mia cena, quello che intorno a quella cena succederà. Mi pare che non veda l'ora di tornarsene, mi sembra una che non appena a casa non pensi ad altro che sciogliersi i capelli.
Mi chiedo se adattarsi significhi questo. Farsi odiosi chignon e poi scioglierli e poi rifarli e poi riscioglierli.
Guardo Leo pagare. Ha dei mocassini in tinta con la polo. Ha fatto la barba, profuma di uomo, saluta la cassiera e le augura una buona serata. E mentre sciorina la sua più naturale cordialità mi chiedo se ci siamo adattati anche noi. Stiamo per farlo? Ci stiamo preparando a diventare dei perfetti noiosi borghesi, fingendo di avere ancora la possibilità di scegliere di non diventarlo?
Lo scorso week end abbiamo concesso a Sofia il suo primo Happy Meal.
Siamo entrati in silenzio, parlando a bassissima voce, forse con lo stesso disagio di uno che ha passato per quarant'anni ininterrotti le sue serate in una balera sporca e puzzosa e poi all'improvviso si è ritrovato alla Scala con addosso ancora la puzza di vino scadente e le carte da briscola in mano.
Solo che al contrario. Eravamo stati alla Scala e ci siamo ritrovati in mezzo ad una bisca clandestina vestiti di seta, nudi.
Ci siamo sentiti nudi.
Abbiamo continuato a stare lì in silenzio, anche se leggeri, sorridendo a Sofia che scopriva il suo primo panino del peggior fast food al mondo, battezzando l'ingresso con il classico scarto del cetriolo.
La gente stava lì come se non avesse fatto altro nella vita.
La gente stava lì come se non avesse fatto altro nella vita.
Riconoscersi ancora diversi da quelle cose, riconoscerlo ci ha sollevato.
Ce lo diciamo spesso in questi giorni io e Leo.
Ci ritroviamo uniti contro questa specie di follia urbana che ci circonda.
Sappiamo che dobbiamo andare via, che un posto, se un posto c'è, non è qui.
Abbiamo definitivamente scoperto, e accettato anche, che ci manca quel dono, forse, quel dono di saperci adattare, quel dono di trovare nelle cose una specie di sazietà.
Abbiamo fame.
Abbiamo voglia di andare a vedere come poterci nutrire altrove di altre cose.
Io porto una 43.
È comoda.
Forse, come tutti, stiamo solo cercando quel posto dove fanno la 43.