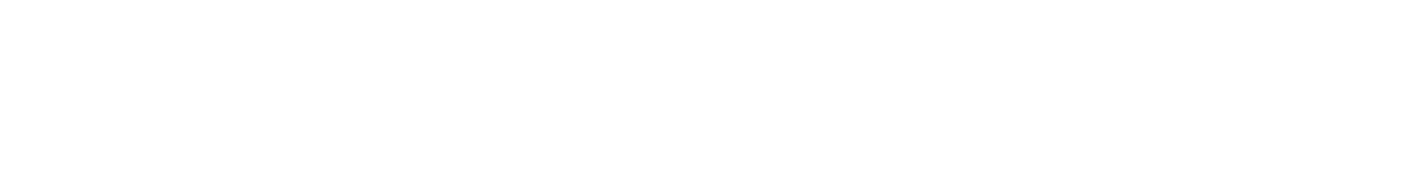Ho 33 anni. Sono donna. Sono mamma.
Praticamente sapete già tutto. Almeno se avete bisogno di collocarmi in qualche statistica, cucirmi addosso qualche status, avete tutte le informazioni che vi servono per inserirmi nell'Italia di oggi.
Mia figlia è arrivata cinque anni fa, quando lo zoccolo della crisi si faceva incontrovertibilmente duro a dispetto di sedicenti cure di volta in volta sciorinate da sedicenti podologi, quando qualcuno cominciava a mentire con la storia dei ristoranti pieni, con la stessa facilità di una hostess a palesare la menzogna sfoggiando il suo miglior sorriso di circostanza, addosso il giubbotto di salvataggio e tutto intorno il panico.
Qualche anno fa sentimmo per la prima volta "choosy". Anche l'italiano medio che nelle file delle etichette stereotipate era uno dei personaggi cardini de "l'inglese e l'ostrogoto" capì il senso dello sberleffo e tra una casa pignorata e l'ennesimo piatto vuoto a cena quella volta, per la prima volta dopo mesi di apatica rassegnazione, ebbe un improvviso moto caldo di gastrite da fame che dalla bocca dello stomaco salì fin sulla testa, si sentì rosso fuoco, e si indignò.
Qualche anno fa sentimmo per la prima volta "choosy". Anche l'italiano medio che nelle file delle etichette stereotipate era uno dei personaggi cardini de "l'inglese e l'ostrogoto" capì il senso dello sberleffo e tra una casa pignorata e l'ennesimo piatto vuoto a cena quella volta, per la prima volta dopo mesi di apatica rassegnazione, ebbe un improvviso moto caldo di gastrite da fame che dalla bocca dello stomaco salì fin sulla testa, si sentì rosso fuoco, e si indignò.
Io ai tempi studiavo filosofia. Me la prendevo con comodo attraversando i grandi corridoi della facoltà, perfettamente inserita in quell'ambiente che nelle mie passate intenzioni ero certa avrei frequentato per tutta la vita. I professori mi avevano soprannominata "la Romantica" per una teoria che avevo formulato e che era stata accolta dal gruppo accademico con entusiasmo.
Vivevo ancora nel mondo delle favole e mentre i pilastri dell'esercizio commerciale della mia città cominciavano ad abbassare le saracinesche io, da brava abitatrice del mondo delle favole, archiviavo il fatto come "libero trapianto verso paesi esotici, culi sodi e tequila boom boom". Olé.
Mia figlia nacque sotto il segno zodiacale della Crisi.
Fu un precipitare. Di mese in mese. Di menzogna in menzogna sciorinata in tv.
Il mio compagno, all'epoca video editor e musicista, si ritrovò sui tetti delle case a installare antenne e digitali terrestri, un tetto sì e mille no, un pagamento sì ed n alla milionesima no, virando magistralmente all'ultimo secondo prima dello sfratto, un mensile pagato sì e certi altri no.
A me, pseudo filosofa con a tratti velleità da scrittrice, praticamente una totale ammissione di colpa ai colloqui di lavoro, con figlia a carico e per quattordici giorni, sedici ore, quarantaquattro minuti e trentatré secondi fuori dalla categoria che ti faceva in un batter d'occhio giovane o vecchio e che poteva garantirti quello straordinario ultimo baluardo di salvezza che era il contratto di apprendistato a vita, non mi rimaneva altro che lavare piatti in pasticceria.
E se buttavo un occhio per affinare le tecniche di uno dei miei hobby, si sa mai, venivo redarguita come fossi stata Eva col peccato originale e rispedita a toglier l'unto dalla pentola. Ché qui siam mica l'America. Qui se nasci lava piatti morirai lava piatti. Nei secoli dei secoli. Se ti va bene.
Sono passati cinque anni.
Se oggi è il giorno dell'arrosto al forno e l'incrostazione non vi si toglie, portatela a me. Oggi non sono più "la Romantica". Oggi mi chiamano Linda. Mastra Linda.
Il mio compagno è invischiato in un traffico di viaggi nel tempo e di salti quantico-temporali: istalla nuove antenne aspettando ancora i pagamenti di quando le tv erano in bianco e nero. Nel frattempo è impazzito e canta "come tutti i gatti vivo sopra i tetti appoggiato all'antenna centrale, io controllo la tv locale".
E a proposito di gatti, la mia gatta, cresciuta a pranzetti che se vi fosse mancato il salmone per le pennette avreste potuto all'occorrenza prenderne a prestito dai suoi, oggi si è rassegnata a mangiare i nostri schifosissimi resti. La storia che non c'è più trippa per gatti non è solo una storia.
Io non sono mica un'economista raffinata, non ho teorie salva mondo, ma mi rendo conto che se è già da un pezzo che io e il mio compagno inganniamo il giorno del pesce con una di quelle scatolette dal contenuto cotonato e petrolchimico, per gli amici tonno, e come noi anche i nostri amici, e gli amici degli amici, a macchia d'olio e di sinergia estesa, come una specie di Facebook della povertà, allora mi vien facile pensare che la giornata del tonno toccherà tutti prima o poi, ma proprio tutti, come una specie di virus, di epidemia.
Dopotutto questo è il mercato globalizzato, bellezza. Nel bene e nel male, finché morte non ci separi.
E in questa specie di guerra dei Roses, al momento l'unico bicchiere mezzo pieno che riesco a intravedere è questo: che solo le aziende di tonno si salveranno.
Dopotutto questo è il mercato globalizzato, bellezza. Nel bene e nel male, finché morte non ci separi.
E in questa specie di guerra dei Roses, al momento l'unico bicchiere mezzo pieno che riesco a intravedere è questo: che solo le aziende di tonno si salveranno.